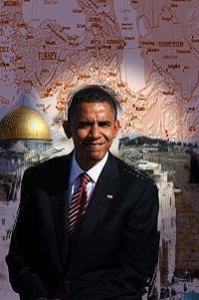MOLTO RUMORE PER NULLA? Sconfitti e vincitori del “Fisichella day” (sic…)
Adesso, dopo la relazione di mons. Fisichella, quello che era considerato da alcuni il sospetto malevolo di un gruppo di docenti prevenuti, è diventato una conferma. Una smilza paginetta, su quattordici, dedicata ai trapianti; le cellule staminali nemmeno nominate. Lo stesso per l’intervento dell’on. Lupi, che ha ignorato gli uni e le altre. Lo stesso per la sterminata serie di saluti, capace di tramortire chiunque, di cui forse solo uno o due era incentrato sui trapianti. Qualcuno ha ancora il coraggio di venirci a raccontare che si è trattato di un convegno accademico su “Etica nella medicina dei trapianti e delle cellule staminali”? Che il vero scopo non era fare una forzatura identitaria all’interno di una operazione schiettamente politica?
Ma l’averlo verificato di persona è una amara conferma. E l’aver avuto ragione nel denunciare ciò che stava accadendo è una triste vittoria, all’interno di una più complessiva sconfitta.
Non credo, quando con i colleghi Curi e Zatti abbiamo denunciato quanto stava accadendo, che avremmo immaginato davvero una tale conclusione: la città blindata pur in assenza di uno scontro sociale reale, e un tale sgomitare di potenti intorno a un alto esponente ecclesiale provvisoriamente assurto al ruolo di icona della libertà di pensiero.
Cominciamo dalla fine. Sarà reato di lesa maestà dire con franchezza che la relazione di mons. Fisichella era, sul piano dei contenuti, una delusione? Qualcuno, forse, avrà potuto trovarci spessore umano e spirituale. E certamente vi erano affermazioni condivisibili e altre meno. Ma, diciamolo con franchezza, lo spessore scientifico era alquanto inconsistente. Non solo perché non ha parlato del tema che gli era stato affidato. Ma perché anche le considerazioni sul rapporto tra scienza e fede sono apparse banali e datate. Per non parlare di alcuni piccoli incidenti, a modo loro illuminanti (non si dice che Dio sta nei dettagli?), come il pronunciare la sola parola difficile del testo, polimero, con l’accento sulla ‘e’ come Calimero: gli sguardi smarriti di alcuni tra il pubblico non hanno osato trasformarsi in sorriso, ma si capiva che avrebbero voluto. E’ stato un degno finale, quindi, da parte di chi officiava la cerimonia, chiamarla ‘lectio magistris’, dimenticando che siamo all’Università.
Detto questo, chi sono gli sconfitti di questa giornata, che qualcuno ha ribattezzato “Fisichella day”? Molti, purtroppo.
Sconfitta la città, inutilmente militarizzata per un pericolo inesistente, a pagare il prezzo di una paranoia senza serio fondamento, assolutamente sproporzionata al rischio reale. Un costo economico, un costo sociale e un costo di immagine assurdo, opportunamente strumentalizzato da qualche potente di turno. Ma che sembra essere diventato parte di un meccanismo comunicativo complesso, su cui varrebbe la pena riflettere – è, questa stessa esibizione di forza, e ancor più questa privatizzazione dello spazio pubblico, un messaggio, e assai significativo.
Sconfitti gli studenti. E su questo qualche considerazione va spesa. Il caso l’abbiamo sollevato noi docenti. Ma il clamore, un certo clamore, l’hanno aggiunto gli studenti. Meglio: alcuni studenti. Meglio ancora: uno solo, coccolato dai media proprio per questo suo ruolo, nemmeno più studente di questa Università, afflitto da un’ansia di protagonismo che si traduce in un linguaggio pirotecnico il cui solo risultato è stato di ritorcersi contro gli studenti tutti. I quali, per lo più, hanno intelligentemente criticato e isolato i pochi piccoli moschettieri del boicottaggio. Ma tanto, chi ne parla, chi ne scrive, chi lo sa? L’opinione che passa è che gli studenti sono facinorosi. Poco importa che da soli abbiano programmato una serie di iniziative di approfondimento su questi temi il cui spessore scientifico è largamente più elevato di quello cui abbiamo assistito il 6 marzo, pur con zero finanziamenti, il supporto di nessuno, e nessuna eco sulla stampa. Ma se l’espressione ‘intelligenza politica’ ha un senso, e la sua mancanza un significato, forse qualcuno dovrebbe riflettere sul risultato che ha ottenuto: sul fatto che quella che avrebbe potuto essere una vittoria – sollevare un problema anche di principio non irrilevante, e discuterne di fronte ad un’arena assai vasta – si sia trasformata in una cocente sconfitta. Va detto, a questo proposito, che una parte del gruppo contestatore, piccola ma reale, ha manifestato intolleranza concettuale nel voler espellere dall’Università una posizione etica religiosamente ispirata: e questo è inaccettabile di principio, moralmente censurabile, e politicamente stupido, perché ha consentito poi ad alcuni, come gli studenti co-organizzatori del ‘convegno’ in cui era ospite Fisichella, di farsi passare per vittime, mentre erano gli artefici iniziali di una modalità di porsi arrogante e prevaricatrice, appoggiata da una fetta consistente di potere cittadino e accademico. L’arroganza e la prevaricazione speculare e, va pur detto, più rozza nel linguaggio e nei metodi di chi ha voluto rispondere con grida sconsiderate ha fatto passare inevitabilmente in secondo piano tutto ciò. Faccio modestamente notare, a contrario, quanto siano state più efficaci ed astute le modalità di contestazione attuate in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, a cominciare dall’acquisizione della complicità della Hack, che ha potuto far sentire la voce degli studenti dove molti non l’avrebbero voluta sentire, e dove meno di tutti il rappresentante degli studenti aveva parlato a nome loro: quella sì una meritata vittoria comunicativa.
Sconfitta l’Università. Che ha abdicato in questa occasione alla sua missione più alta, cedendo alla protervia egemonica di alcuni, tutti amici degli amici. Non i cattolici. Guai a far passare questo messaggio: cattolici ve ne erano anche tra chi ha criticato le modalità del convegno. Ma una specifica componente cattolica organizzata, che ha un nome e un cognome. Che si è costruita la sua piattaforma di visibilità, presumibilmente anche in vista delle elezioni rettorali, in cui giocherà un ruolo importante, e si è capito per chi. Si può leggere in questa chiave la piccola gaffe del preside della facoltà di medicina, probabilmente il vero vincitore occulto della giornata, che ha chiamato l’onorevole Lupi ‘monsignore’: qualcosa di più di un lapsus. L’Università ha perso perché alcuni, al suo interno, hanno voluto fare una arrogante furbata, e gli è stato permesso, anzi, si è collaborato a realizzarla; ha perso, perché ha perso il controllo della situazione, perché come un apprendista stregone ha messo in moto un meccanismo che non è stata più in grado di controllare; ha perso, perché è stata espropriata di una sua stessa iniziativa, privatizzata dai promotori a proprio uso e consumo, e utilizzata come passerella da tutto ciò che non avrebbe dovuto essere lì dentro; ha perso perché è stata soltanto la sede di un evento e il suo megafono, ma è stata, di fondo, tragicamente assente.
Sconfitti noi, i docenti che hanno sollevato il caso. Che volevano solamente innescare una discussione civile, ma che nel vedersela presa in mano dagli interlocutori più disparati, per i motivi più disparati, in un impressionante gioco di strumentalizzazioni reciproche, hanno scoperto di aver creato loro malgrado un gigantesco spot pubblicitario non solo e non tanto per monsignor Fisichella, quanto per interessi altri e più alti, che poco avevano a che fare con il caso in questione. E non mi riferisco alla Fondazione che ha organizzato il convegno, che di suo fa un onesto mestiere, certo corresponsabile, ma forse strumentalizzata anch’essa da interessi che passavano largamente sopra la sua testa. Paghiamo, evidentemente, un peccato di ingenuità: non pensavamo si sarebbe arrivati a tanto, e non avevamo valutato nel giusto modo le conseguenze del nostro gesto. Paghiamo, probabilmente, un peccato di presunzione intellettuale: il pensare che una libera discussione tra liberi cittadini, gettata nello spazio pubblico, possa rimanere tale, senza rischiare di venire cannibalizzata da altri. Paghiamo, anche, un banale peccato di libertà individuale: voler dire quello che si pensa, da persone che non hanno ruoli di potere e non aspirano ad averne, per motivi che con il potere non hanno nulla a che fare. E’ triste, quindi, pensare di avere avuto ragione ma, alla luce di quanto è successo, dover credere che sarebbe stato forse meglio non sollevare il caso, lasciare che gli interessi di alcuni continuassero a spadroneggiare con la solita protervia, tanto non c’è niente da fare. Non voglio pensarlo e non voglio crederlo. Ma, in questo momento, prevale l’amarezza: la vittoria, apparentemente, è ‘loro’. Una lezione utile, tuttavia, una piccola vittoria, c’è anche per noi: ci siamo accorti che è bastato poco per disturbare il manovratore, molto al di là delle nostre intenzioni. Segno che avevamo colpito nel segno… E che discutere, dopo tutto, può davvero servire a qualcosa.
Sconfitti, in parte, i media. Che sono stati, va pur detto, il mezzo attraverso il quale la discussione si è sviluppata, e in questo senso un formidabile strumento di democrazia. Che hanno svolto un ruolo di trasparenza e di pubblicizzazione fondamentale, mettendo in luce, in alcuni casi, ciò che avrebbe preferito rimanere in un assai più pratico cono d’ombra. E che hanno informato come doveroso degli sviluppi della situazione, mettendosi in ascolto delle diverse voci della città: e di questo va dato loro atto – questa, se vogliamo, è la loro vittoria. Ma che hanno commesso alcuni peccati abituali, che hanno avuto un ruolo nel caso specifico. Perché hanno titillato, per far fermentare la notizia, i malsani desideri di visibilità di alcuni, andandoli a cercare prima ancora che questi cercassero loro. Perché hanno usato talvolta un linguaggio roboante che si è trasformato, come spesso accade, in una profezia che si autorealizza. Perché non hanno informato, con le dovute eccezioni, su alcuni dati di base che sono pur rilevanti (chi rappresenta chi, quanto conta, al di là di quanto forte abbaia). Perché, quando si è arrivati al punto, si sono accontentati dei messaggi provenienti dal ‘centro’ senza cercare contraltari tra le voci di ‘periferia’, che avevano invece ascoltato fino a quel momento. Perché molti giornalisti – e lo sappiamo per esperienza personale, visto che ce lo chiedevano – sapevano che c’erano in ballo importanti questioni elettorali interne all’università, e forse anche alleanze e interessi trasversali, che riguardano la città nel suo complesso e il suo futuro, con grandi interessi economici in gioco, e che sarebbe stato interessante indagare. Ma non uno che ne abbia scritto. Mentre altri, ed è più grave, non se ne sono resi conto. E solo pochi, avendolo avvertito, sono stati tacitati in anticipo dalle reazioni degli interessati.
Sconfitta, mi pare, la Chiesa: silente, probabilmente con buone ragioni, anche perché di fatto essa stessa esautorata, a livello locale, e rappresentata quindi dai suoi principi papalini. Una Chiesa la cui immagine ancora una volta viene associata al potere e ai suoi rappresentanti: che, non a caso, hanno fatto a gara – anche quelli non credenti, come ci stiamo abituando a vedere in questo tempo e in questo paese in cui il tasso di clericalismo è spesso inversamente proporzionale alla fede – a fingere di omaggiarla, stringendosi intorno a monsignore (ah, quella sigla che precedeva il suo nome, quel SER – Sua Eminenza Reverendissima – che non usa nemmeno più altrove, e che in Università, con tristo servilismo, spiccava incongrua ma significativa). Certo, questa strumentalizzazione reciproca giova al suo potere, ed è per questo che viene con successo praticata da entrambe le parti, ma specularmene si trasforma in una controtestimonianza che non fa onore al messaggio che vorrebbe e dovrebbe trasmettere.
Sconfitta, certamente, la politica, quella che si occupa di problemi reali, che cerca di affrontarli e risolverli. Ma vincenti, totalmente vincenti, i politici, invitati e no (e vale anche per i piccoli politici in sedicesimo oppositori dell’iniziativa, che anche loro si sono guadagnati il loro quarto d’ora di celebrità a spese della città): astutamente preoccupati di gestirsi un’immagine di cui poi i giornali parlano, accuratamente lontana dagli interessi che poi maneggiano, dei quali invece cercano di far parlare meno. Non è un caso che in questa vicenda, molti media e tutta la politica d’accordo, il tema sia diventato, alla fine, la libertà di parola di uno, mentre era il suo esatto opposto: il suo monopolio, il suo uso prevaricatore, da parte di pochi.
Un considerazione finale. Raramente abbiamo visto, a livello locale, una così consistente parata trasversale di potenti stringersi intorno a un alto prelato: e mai, credo, in questa Università. Un segno dei tempi, certo. Ma anche qualcosa di più. Guardando quella impressionante sfilata di facce, tutte maschili (non me ne voglia la presidentessa della Fondazione organizzatrice, se non l’annovero tra coloro che in quella sede contavano davvero), mi sono venute alla mente certe grottesche caricature di George Grosz. C’erano tutti: il potere politico – nelle sue varie sfaccettature, purtroppo indistinguibili nonostante la diversità di schieramento – il potere ecclesiastico, il potere baronale. Anche il potere economico, assente nei suoi rappresentanti, ma corposamente rappresentato nei suoi interessi. E una tale potenza di fuoco, un tale unanimismo, una tale volontà di cantare all’unisono, al cittadino comune, che non è uomo di potere e che non spera di diventarlo, non può che suscitare un’amara inquietudine, e produrre un brivido freddo alla schiena.
Stefano Allievi
“Il Mattino”, 21 marzo 2009, p. 29