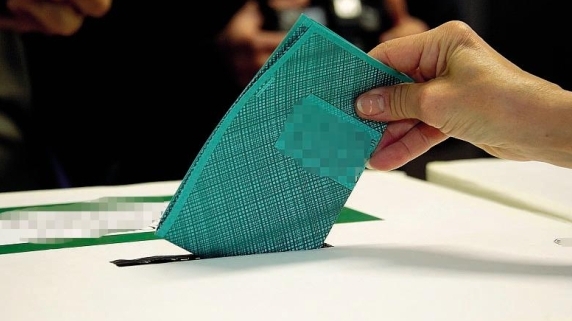A malinquorum. Qualche riflessione post-referendum
Salvo i dettagli su numeri esatti e percentuali, il referendum è finito come tutti sapevano che sarebbe finito: con il mancato raggiungimento del quorum, e la non vittoria dei sì, maggioritari tra i voti espressi ma insufficienti e dunque, in definitiva, inutili.
A questo punto qualche riflessione è d’obbligo. Sull’utilizzo del referendum, per cominciare. In un paese in cui la politica non decide nulla, nemmeno (men che meno) sui grandi principi e le battaglie valoriali – si pensi ai diritti civili, alle coppie omogenitoriali e al riconoscimento dei loro figli, al principio di autodeterminazione e al fine vita, e tante altre questioni pure sentite e discusse – è inevitabile che si debba attendere la supplenza della magistratura, o appunto i referendum. Detto questo, il suo uso è spesso più tattico – politico nel senso di politicante – che di principio. L’abbiamo visto anche in questa tornata referendaria. Se il referendum sulla cittadinanza aveva valore di battaglia civile – di allargamento, molto concreto e sostanziale, della sfera dei diritti – gli altri sono sembrati a molti più una resa di conti interna a un campo (in questo caso, al mondo della sinistra, dove alcuni erano chiamati a votare contro norme che avevano approvato in passato): un tentativo, legittimo ma obliquo, di far pesare leadership e organizzazioni in funzione di indirizzo politico e egemonia ideologica su un’area politico-elettorale. E il fatto che quattro quesiti su cinque fossero di questo tenore, e per giunta su aspetti molto tecnici e in qualche caso opinabili nelle loro conseguenze, ha di fatto oscurato e marginalizzato – e quindi danneggiato – la discussione sull’unico che aveva un vero valore civile. E forse è il momento che i promotori di referendum comincino a ragionare sugli effetti che ha il non vincerli. La situazione non rimane uguale a prima: è un sostanziale e sostanzioso passo indietro, che finisce per legittimare e rinvigorire i conservatorismi anziché le spinte innovative.
Un gigantesco interrogativo pesa anche sul mantenimento del quorum stesso. Non si capisce (o meglio si capisce benissimo, ma sono ragioni in buona parte interessate) perché alle elezioni il quorum non ci sia, e una maggioranza possa essere determinata, in linea teorica, anche con un solo votante, senza soglia minima, mentre per i referendum sì. A rigore, a voler essere coerenti con la logica della rappresentatività, se votasse solo metà del corpo elettorale dovrebbe eleggere solo la metà dei rappresentanti. In un periodo storico che conosce un calo drastico e per ora apparentemente irreversibile, in tutto l’Occidente, della partecipazione elettorale, avrebbe senso, dunque – oltre che promuovere nuove forme di partecipazione – introdurre un quorum pesato non sul numero degli elettori (il corpo elettorale nella sua interezza), ma parametrato al numero di elettori che realmente si è recato alle urne nelle elezioni precedenti, o addirittura l’abolizione del quorum stesso. Altrimenti possiamo dire addio all’istituto referendario in quanto tale: magari se ne promuoveranno tanti (con la firma elettronica la soglia di consensi necessari per presentarli è diventata molto bassa), ma non ne passerà più nemmeno uno.
Infine, una riflessione seria va fatta sulle forme stesse dell’esercizio del voto. Ma è mai possibile che nel 2025 non si sia ancora capaci di formulare dei quesiti che facciano riferimento al contenuto di ciò per cui si vota, anziché a formule giuridiche esoteriche, incomprensibili anche a un plurilaureato? È anche così che si uccide la democrazia, insieme ai timbrini sul certificato elettorale cartaceo (ma perché non basta la carta d’identità?) e alle matite copiative, e altri ridicoli rituali burocratici senza alcun senso della realtà e della storia, impensabili e persino indecenti in epoca di intelligenza artificiale. E la responsabilità è di tutti, destra sinistra e centro. Ma è mai possibile che non si sia capaci di mettere in piedi una commissione bipartisan che, copiando da quanto accade in altri paesi, faccia uscire le forme dell’esercizio della democrazia da un ottuso formalismo burocratico ottocentesco, che non tollereremmo in nessun altro settore della vita sociale, e che con certezza incide pesantemente sui livelli di comprensione e di partecipazione democratica? La forma è il contenuto, ed è incomprensibile che non lo si capisca. A meno che non sia una volontà implicita. Che non rimanda, tuttavia, alla formula gattopardesca del cambiare tutto, o almeno qualcosa, perché nulla cambi. Qui siamo più indietro: non si fa nemmeno finta di cambiare qualcosa. Prevale, semplicemente, la forza d’inerzia. La forza più grande della storia, come diceva Tolstoj. La più ingombrante e deleteria, nel nostro caso.
Senza quorum?, in “Corriere della sera – Corriere del Veneto”, 10 giugno 2025, editoriale, pp. 1-2